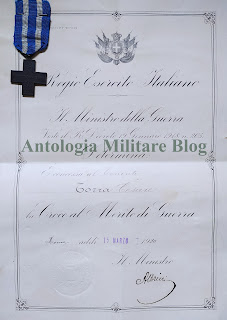Dopo la storia del generale Enrico Secchi, il suo ottimo ed omonimo nipote ci dona un altro prezioso contributo: stavolta, il protagonista sarà Bassano Secchi, figlio del generale Enrico, ed a sua volta destinato a una brillante quanto movimentata carriera militare nelle file del Regio Esercito prima, e dell'Esercito Italiano poi. Tale pubblicazione lo intende, peraltro, ricordare proprio nel centenario dalla sua nascita.
***
Bassano
Secchi nacque il 24 agosto 1921 a Como, dove il padre Enrico comandava la locale Compagnia esterna dei Carabinieri Reali.
Note storiche circa la famiglia Secchi
La famiglia Secchi, però, è originaria di Lodi e le prime
notizie su di essa, tratte dall’Archivio Storico della Biblioteca Comunale
della città, risalgono al XV secolo e si sintetizzano nelle seguenti:
“Famiglia antica
di Lodi di Partito Guelfo. Si trova in parentela con varie Nobili Famiglie di
Lombardia ed un ramo passò ad abitare anche a Milano.
Angela nel 1655 lasciò
eredi le Orfane di Lodi d’ogni suo avere e una messa quotidiana in S. Francesco alla
Cappella di Famiglia della B. V. di Caravaggio.
Ca’ de’ Secchi
cascinale di loro fondazione sotto Senna.
Bertolino Canonico della
Cattedrale di Lodi andò a Roma nel 1457 per incarico dei Deputati dell’Ospitale
Maggiore che stavano costruendo onde ottenere conferma di privilegi e decreti
d’annessione degli altri Ospitali dal Papa.”
Alla fine del secolo XVIII, la Famiglia Secchi possedeva un
consistente patrimonio immobiliare, ma i tre fratelli Secchi (Bassano, Angelo e
Giacinto), entusiasti seguaci dei nuovi ordinamenti liberali, dovettero temere,
per tale motivo, per la loro libertà ed incolumità personale. I due fratelli
minori - Angelo e Giacinto -, quindi, decisero di abbandonare la loro bella
Lombardia e di andare in Paesi più liberi e democratici. Pertanto, svenduto il
loro patrimonio immobiliare in tutta fretta e diviso il ricavato in parti
uguali, i due fratelli minori abbracciarono Bassano, dicendo che sarebbero
emigrati in America, ma, poi, di loro non si ebbe più alcuna notizia.
Bassano
(1790-1860), che non aveva voluto ad alcun costo lasciare la sua città e
con una buona cultura umanistica e matematica, nonostante le difficoltà dovute
alla restaurazione asburgica, riuscì a trovare il posto di Segretario ed
Economo, presso il “Collegio delle Dame Inglesi”, fondato da una nobile dama
venuta dall’Inghilterra, di nome, Lady Mary Hadfield Cosway. Bassano fece subito
colpo sulla segretaria e dama di compagnia di Lady Cosway, Anna Elmi, appartenente ad una distinta famiglia di Foligno, per cui
si sposarono ed ebbero nel 1827 un unico figlio di nome Francesco.
Francesco (1827-1874)
studiò nel Collegio stesso delle Dame Inglesi, e incline alle arti e specialmente
alla musica, fu fatto anche studiare presso valenti maestri dell’epoca. A venti
anni, nel 1847, sposò Virginia Cavenaghi,
appartenente ad una ricca famiglia di Crema, proprietaria soprattutto
di immobili. Pochi mesi dopo il matrimonio, nel marzo 1848, Francesco, allevato
dal padre nelle idee liberali, partì con altri patrioti per Milano, ove
partecipò alla rivolta contro l’oppressore asburgico, combattendo durante le
“cinque giornate” contro le truppe austriache del Maresciallo Radetzky e
rientrando a Lodi solo dopo il pieno successo dell’insurrezione. Per questa sua
partecipazione attiva alla prima guerra del Risorgimento, dopo il 1849, quando
il governo austriaco ritornò in Lombardia, Francesco dovette subire ritorsioni
da parte della polizia imperiale, ma ebbe la grande soddisfazione, nel 1859, di
vedere la sua terra finalmente libera e riunita in un’unica Nazione, la tanto sospirata
Italia. Francesco, a parte questi problemi di carattere politico, divenne un
imprenditore, fra l’altro, nell’industria del teatro lirico, nel cui settore si
distinse, ottenendo peraltro più soddisfazioni morali che materiali.
Ebbero cinque figli, ma un solo maschio Bassano (1860-1911),
che, rimasto orfano del padre a soli tredici anni, si affiancò subito alla
madre nella guida della famiglia, dove vi erano quattro sorelle da seguire e accollandosi,
ancora da ragazzo, responsabilità da uomo. Conseguito il diploma di Istituto
Tecnico, vinse per concorso un posto di funzionario nell’Amministrazione
Comunale di Lodi, divenendo col tempo Capo Ufficio del suo settore. Bassano si
sposò felicemente nel 1884 con Zaira Wilmant,
proveniente da una ricca famiglia lodigiana di editori e patrioti. Tra i numerosi fratelli di Zaira vi erano Tieste Wilmant e, soprattutto, Vero Wilmant, destinato a una brillante carriera nel Regio Esercito.
Bassano Secchi e Zaira Wilmant ebbero due figli, Francesco,
laureato in giurisprudenza, Segretario Generale degli Istituti di Beneficenza del
circondario di Lodi e tenente di complemento d’artiglieria durante la prima
guerra mondiale ed Enrico
(1887-1963), che intraprese la carriera militare e partecipò alla
guerra di Libia, alla prima e alla seconda guerra mondiale, divenendo generale
di brigata dei Reali Carabinieri. Enrico, sposatosi con Francesca Moriondo,
proveniente da una distinta famiglia di Asti, ebbe due figli di cui una
femmina, Domitilla, e un maschio, Bassano, appunto.
Giovinezza e inizio della carriera militare
Bassano, che a
causa dei numerosi trasferimenti del padre aveva avuto un trascorso
scolastico un po’ travagliato, cambiando continuamente scuola tra Lucca, Lodi,
Grosseto, Bologna, L’Aquila e Bari, nel 1935 giunse a Milano,
dove venne iscritto al Regio Ginnasio “Giuseppe Parini”, ove frequentò,
finalmente senza interruzioni, la Va Ginnasio e le tre classi liceali,
dopodiché si iscrisse alla Regia Università degli Studi di Milano (allora
dislocata in Via Torino) nella Facoltà di Giurisprudenza.
Il desiderio del padre era che esercitasse la libera
professione, ma gli avvenimenti, che sconvolsero, non solo l’Italia, ma tutto
il mondo, diedero a tali proponimenti una svolta completamente diversa.
Nell’agosto 1939, infatti, scoppiò la Seconda guerra mondiale e, nel giugno
1940, anche l’Italia entrò nel conflitto. Bassano stava frequentando
il II° anno di Università, quando il 1° marzo 1941 venne chiamato alle armi e
destinato al 62° Rgt. Ftr. Mot. della D. “Trento” a Trento. La sua chiamata era
seguita alla decisione del Governo di fare partecipare al conflitto subito gli
Universitari della classe allora più giovane e, cioè, proprio il 1921. Tutti
questi ragazzi dovevano diventare Ufficiali, ma il Corso Allievi, proprio per
loro, venne modificato per poterli meglio preparare per i futuri compiti in
guerra; il Corso venne portato da 6 mesi a 12 mesi, diviso in due fasi, la
prima presso Reparti operativi e la seconda presso le Scuole di Specializzazione.
Verso la fine di marzo, venne formato un Battaglione
Allievi che fu inviato a Vipiteno e inquadrato in un'unità della Guardia alla Frontiera (G.a.F., particolari truppe, con caratteristiche alpine, costituite allora
per la difesa delle frontiere, specialmente sulle Alpi). Lo scopo di questo
trasferimento era quello di formare il fisico degli Allievi alle fatiche della
vita militare; perciò, oltre agli studi specifici, non mancarono: giornaliere
esercitazioni di addestramento al combattimento con spostamenti, naturalmente
sempre a piedi, in tutte le zone montuose circostanti; ginnastica atletica;
continue esercitazioni di tiro con tutte le armi di reparto e individuali
(mitragliatrici “Breda” e mortai da 45 e da 80 compresi) e, “dulcis in fundo”,
ogni venerdì una marcia con partenza all’alba e rientro all’imbrunire, con
zaino al completo e armamento. Alla fine di maggio, il Reparto si spostò a
Bressanone (tappa a piedi, con tutto il bagaglio personale e tutto l’armamento
sulle spalle), da dove cominciò il Campo mobile. La 2a Compagnia, alla quale apparteneva Bassano, fece soste di
tre o quattro giorni ciascuna, a Rio di Pusteria, a Spinga e nella stessa
Bressanone (naturalmente trasferimenti sempre a piedi). Il 15 giugno, conferito
a tutti gli Allievi idonei fisicamente e previo esame sulle materie studiate
(purtroppo, vi furono delle bocciature, accolte con molta delusione da parte
degli interessati) il grado di Sergente Allievo Ufficiale, il Battaglione
rientrò a Trento. Ai primi del mese di luglio, Bassano, a seguito di
concorso per titoli, venne trasferito nel Corpo Automobilistico ed avviato ad
un Corso di addestramento preparatorio per la specialità presso il 4°
Autocentro di Verona, dove cominciò a conoscere meccanicamente e ad apprendere
praticamente la guida di tutti gli automezzi allora in dotazione all’Esercito.
Il Corpo Automobilistico era stato costituito solo nel
1936, per gestire tutti i trasporti e, nel campo della motorizzazione, le
riparazioni e i rifornimenti a favore di tutte le Unità dell’Esercito.
 |
| Bassano Secchi allievo ufficiale a Torino nel '41-'42. |
Il 1° settembre, Bassano fu assegnato alla Scuola Allievi Ufficiali del Corpo di
Torino, sita in Via Brione (poi sede della Ia O.R.E.), e dopo sei
mesi di Corso, superati gli esami finali, fu nominato S.Tenente con anzianità
16 marzo 1942. Sotto la stessa data si presentava al 10° Centro Automobilistico
di Napoli, dove prestò servizio per circa cinque mesi come Comandante di
autosezione. Nel frattempo, dopo aver presentato ufficialmente domanda per
essere inviato al Fronte, incominciò a premere insistentemente sul padre perché
lo aiutasse a essere destinato in Russia, dove altri suoi colleghi ed amici
erano già stati avviati.
Benché naturalmente riluttante, il padre, sempre
pressato da Bassano, si
recò a Roma, al Ministero della Guerra, dal Direttore Generale degli Ufficiali,
Generale Cappa, suo compagno di Accademia, che, con stupore e, nel contempo,
con ammirazione per quella inconsueta richiesta, provvide a tale assegnazione.
Così, il 22 agosto 1942, giunse il relativo dispaccio che destinava il S.Ten. Secchi al X°
Autoraggruppamento di Manovra (Col. Montrucchio) - 60° Autogruppo (Magg. Mazzei
e, poi, Ten. Col. Commento) - 253° Autoreparto Pesante (Capitano Falanga), operante
alle dirette dipendenze dell’8a Armata schierata sul Fronte Russo.
Partito da Napoli e dopo alcune soste presso i Distaccamenti di Brescia e di
Piacenza del 3° Rgt. Autieri di Milano (i Centri Autieri avevano assunto la denominazione
di Reggimenti, in quanto il Corpo Automobilistico sarebbe dovuto diventare
Arma), ai primi di settembre, Bassano
raggiunse il Comando sosta di Bologna, da dove, dopo una settimana, fu inviato
a Verona; da questa città, verso la metà di settembre, partì con la tradotta
militare per il Fronte Russo. Il viaggio iniziò sotto un diluvio, per cui, dopo
una sosta a Trento, il treno dovette fermarsi a Bronzolo, a causa di una frana
che aveva bloccato la linea ferroviaria. Dopo due giorni, riprese il viaggio,
che seguì il seguente itinerario: Bolzano - Brennero - Innsbruck - Rosenheim -
Salisburgo - Linz - Vienna - Bratislava - Leopoli - Kiev - Karkov - Millerovo.
La campagna di Russia
In quest’ultima località ebbe termine il tragitto
ferroviario e tutti i militari trasportati furono smistati ai vari Reparti di
appartenenza. Bassano,
quindi, proseguì per Voloscilovgrad, dove si presentò al Comando del X° Autoraggruppamento.
Dopo una breve sosta, raggiunse - al comando di una autocolonna diretta a nord,
lungo l’itinerario: Certkovo - Kantemirovka - Rossohs, (lasciando pertanto
l’Ucraina ed entrando proprio nel territorio russo) - il 253° Autoreparto,
dislocato nel paese di Stojanovo-Blinskj, presso il capoluogo di Ostrogoshsk, a
sud di Voronesh. La nuova sede si trovava a circa 80 Km a nord di Rossohs - dove
era schierato il Corpo d’Armata Alpino (DD. Tridentina, Cuneense, Julia), ala
sinistra dell’8a Armata Italiana - e a ridosso delle linee tenute
dalle Unità Ungheresi e da Unità Tedesche. In questa sede, il 253° Autoreparto
rimase fino all’alba del 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata.
Durante questo periodo, il Reparto lavorò duramente con autocolonne continue in
zone particolarmente sottoposte a bombardamenti aerei, ad infiltrazioni di
elementi dell’Esercito Sovietico e a improvvisi attacchi di partigiani, in
quanto le linee nemiche distavano soltanto qualche chilometro.
 |
| Cimitero di guerra italiano in Russia nel '42-'43. |
Verso la fine di novembre del 1942, Bassano contrasse una
dolorosa tendosinovite ad entrambi i talloni di Achille, che, risoltasi
positivamente in breve tempo per quanto riguarda il piede sinistro, nel piede
destro, malamente curato all’inizio, si trasformò in un principio di necrosi
all’altezza del tallone stesso. Bassano,
peraltro, non volle, come consigliato dai medici, essere ricoverato in un Ospedale
Militare, poiché ciò avrebbe voluto dire lasciare il suo Reparto per chissà
quanto tempo. Per fortuna trovò presso una vicina Unità un ottimo medico
militare, valido chirurgo da civile, che sottopose la parte infetta della gamba
ad un intervento, asportando, solo mediante un bisturi ed una speciale forbice
(l’attrezzatura sanitaria in loco era molto precaria) e senza alcuna anestesia
locale, la carne già incancrenita e portando allo scoperto la carne ancora
viva. Ogni giorno, poi, si doveva provvedere a eliminare la parte che,
ricrescendo, continuava ad infettarsi; in un primo tempo, sempre tagliando e,
successivamente, quando l’azione cancrenosa incominciò ad attenuarsi, bruciando
col nitrato d’argento. Comunque, Bassano, sia
pur zoppicando, continuò, sempre contro il parere dei sanitari che temevano serie
complicazioni e che pertanto insistevano per ricoverarlo in un ospedale, ad
espletare i suoi compiti e, grazie alla grande medicina dei vent’anni, riuscì a
guarire contro ogni pronostico!
Intanto, i giorni scorrevano e, nel dicembre 1942,
incominciarono a pervenire notizie sull’avvenuto massiccio attacco delle Armate
Sovietiche contro l’ala destra e il centro dell’8a Armata, che iniziavano
a cedere.
 |
| Prigionieri russi scortati da truppe tedesche nel '42-'43. |
La sera del 31 dicembre 1942, il Comandante dell’Autoraggruppamento
(Col. Montrucchio) venne a cena presso la mensa Ufficiali
del 253° e, al termine del pasto, nel brindare e fare gli auguri a tutto
l’Autoreparto, al suo Comandante e agli Ufficiali, comunicò che, in caso di
arretramento delle linee anche nella zona, al 253° sarebbe stato assegnato il
compito di retroguardia, concludendo con una frase che si può così
sintetizzare: “Al migliore Reparto
l’onore dell’incarico più pericoloso”. Il 253°, infatti, grazie alle
particolari qualità militari, morali e di carattere del suo Comandante, - che
era riuscito a forgiare a sua somiglianza Ufficiali, Sottufficiali e Autieri -
era considerato il Reparto di punta del X°. Comunque, l’incarico di
retroguardia, dati i precedenti in materia, era da considerarsi, più che
pericoloso, da disperati, ma tutti gli Ufficiali se ne sentirono orgogliosi.
Dopo il 10 gennaio, la temperatura calò bruscamente, raggiungendo i 30/40 gradi
sottozero e l’offensiva sovietica si scatenò contro le antistanti linee
tedesche e ungheresi. Il 253° venne subito impiegato in appoggio alle Unità
corazzate germaniche e il 13 gennaio due autocolonne cariche di carburante per
la 227a Divisione corazzata tedesca, di cui una comandata proprio da
Bassano,
vennero attaccate da reparti motorizzati russi.
 |
| Nostri mezzi bloccati nella neve nell'inverno 1942-1943. |
Gli scontri furono brevi, ma
violenti; i reparti sovietici, affrontati con estrema decisione, si ritirarono,
le due autocolonne subirono le prime perdite in uomini e mezzi, ma i compiti
previsti furono portati regolarmente a termine. Il 15 sera, iniziarono violenti
bombardamenti aerei; venne dato subito l’ordine di approntare il 253° - ultimo
Autoreparto, come previsto, rimasto a Ostrogoshsk - per la ritirata. Incominciò
il carico delle ultime truppe rimaste a difesa della città; dopo mezzanotte,
cessò l’attacco aereo ed entrò in azione l’artiglieria sovietica; Ostrogoshsk
era ormai in fiamme e, alla luce degli incendi, il 253° continuava ad operare
con calma, destreggiandosi tra macerie e caduti di tante nazionalità; i reparti
nemici stavano ormai entrando nella periferia della città praticamente deserta.
All’alba del 16 gennaio 1943 iniziò il ripiegamento, sicuramente la fase bellica
più crudele, più dolorosa e più sanguinosa che un’Armata Italiana dovette mai
affrontare durante tutto il conflitto.
 |
| Carro armato russo T34 catturato. |
Il 253°, carico di uomini, di armi e di materiali, ripiegò
a scaglioni; l’ultimo scaglione, con il Capitano Comandante e il S.Ten. Secchi, suo Ufficiale
Addetto e V. Comandante, lasciò, verso le sei del mattino, la città quasi ormai
distrutta, inseguito da nuclei di carri armati sovietici. Malgrado che venisse
a lungo bersagliato da cannonate e raffiche di mitragliatrice, lo scaglione
riuscì a sottrarsi al nemico e a riunirsi al resto del reparto; proseguirono
perciò insieme, sotto continui bombardamenti aerei, lungo la linea di ritirata:
Aleksievka, Budiennj, Valuiki, dove vi fu un violento e prolungato scontro con
truppe siberiane e mezzi corazzati nemici e dove il Reparto, reagendo con tutte
le proprie forze e con accanimento e riuscendo perciò a sganciarsi, subì
fortissime perdite in uomini e mezzi.  |
| Mezzi e animali intrappolati nella neve. |
Alle prime luci del 19 gennaio 1943
(ricorrenza di S. Bassano), i resti del 253° raggiunsero Karkov. In questa
località, l’Autoreparto, sebbene decimato negli uomini e con il parco mezzi
quasi distrutto, venne fermato dal locale Comando Italiano e, rinforzato con
altro materiale, subito reimpiegato a sostegno della vicina zona di Kupiansk,
già minacciata dalle forze nemiche. Ma anche Kupiansk cadde e i combattimenti
si spostarono nella zona di Karkov, ormai sotto tiro delle artiglierie russe.
 |
| Tramonto durante la ritirata. |
Verso la fine di febbraio, il 253°, rinforzato da altre unità motorizzate e
carico di uomini e materiali, iniziò un ulteriore spostamento verso ovest,
lungo la direttrice: Sumy - Romny - Priluki, fino a raggiungere, - dopo
continui bombardamenti aerei, attacchi improvvisi di reparti motorizzati e corazzati
sovietici, imboscate di partigiani - la città di Kiev.
 |
| Ultime fasi della ritirata, febbraio 1943. |
Qui, in pratica, finì la
ritirata vera e propria, perché i successivi spostamenti furono effettuati in ambiente
relativamente più sicuro, pur se sempre sottoposti a continui attacchi aerei.
Da Kiev il 253° si spostò a Nescin, dove fu ancora impiegato in diversi compiti
a carattere logistico. Verso la fine di marzo, l’autoreparto lasciò questa
ultima località e, superata Cernigov, entrò nella Russia Bianca, raggiungendo
Gomel. Qui finalmente si riunì al X° Autoraggruppamento dal quale, da circa due
mesi e mezzo, aveva perso ogni contatto, mentre veniva impiegato da tutti i
Comandi, sia italiani, sia tedeschi, via via incontrati, senza un attimo di
sosta, malgrado le forti perdite subite, talché per un certo periodo era stato
dato - nella tragica situazione del momento, ove intere unità sparivano
travolti dalla furia bellica - per disperso.
 |
| Villaggio incendiato, raggiunto durante le ultime fasi della ritirata (febbraio 1943). |
Ora finalmente il 253° poteva riorganizzarsi, contare i
suoi Caduti, curare i suoi feriti o ammalati, dare respiro a tutti coloro che
avevano superato con coraggio, con sacrificio, con dedizione assoluta e,
diciamo pure, anche con una buona dose di fortuna, ogni sorta di pericoli.
Aveva percorso centinaia di chilometri, continuamente attaccato,
sanguinosamente colpito da un nemico sempre in agguato, torturato dalle
intemperie di un clima letteralmente agghiacciante, lasciando lungo le piste
innevate uomini e mezzi, ma riuscendo a ribattere colpo su colpo, a superare
ogni ostacolo, a resistere anche quando tutto sembrava finito, a compiere,
infine, sempre e ovunque, il proprio dovere con serenità e consapevolezza,
senza mai compiangersi o lamentarsi.
Nella zona di Gomel erano state radunate
tutte le Unità italiane che, convenientemente completate, potevano essere
ricostruite e impiegate: un Corpo d’Armata su tre Divisioni con supporti vari e
un Autoraggruppamento, il X°. Ma, verso la metà di aprile, giunse l’ordine di
rientro in Patria e anche il 253°, con varie tradotte, lasciò la zona di
guerra. Così per Bassano aveva
termine, dopo circa sette mesi, uno dei periodi più importanti della sua vita,
che, da ancora ragazzo, lo aveva trasformato in uomo, attraverso esperienze
certo crude e dolorose, ma determinanti per la formazione del suo carattere.
Al comando di una parte del suo Reparto, Bassano iniziò
un viaggio al contrario, ma simile a quello dell’arrivo: Gomel-Luminez-Leopoli-Bratislava-Vienna-Linz-Salisburgo-Rosenheim-Innsbruck-Brennero-Vipiteno.
Qui, i militari scesero, fermandosi per visite mediche di controllo e per la
disinfestazione, mentre i mezzi, presi in consegna da militari del 4°
Reggimento Autieri, proseguivano per Verona. Dopo la disinfestazione, i
militari furono trasferiti a Dobbiaco, dove rimasero per quindici giorni in
quarantena e dove Bassano potè riabbracciare il padre, che prestava servizio a
Trento; al termine di questo periodo, raggiunsero Verona. Colmati i vuoti in
uomini e materiali, l’Autoreparto si spostò, prima a Montichiari (Brescia) ed,
infine, a Livorno, ove venne impiegato in attesa di nuova destinazione.
L'armistizio
Ma giunse l’8 settembre 1943, data dolorosa e apportatrice
di nuove sventure e lutti. Nella confusione indescrivibile del momento il 253°
dapprima si oppose con le armi ai reparti tedeschi, che volevano catturarlo, ma
alla fine, con l’arrivo di ulteriori forze germaniche e a seguito di ordini superiori
dati per iscritto, resi inefficienti le armi e i mezzi in dotazione, si sciolse.
I reparti tedeschi, disarmati gli italiani, consegnarono in
caserma la guarnigione, ma Bassano col suo capitano e altri coraggiosi, non
volendo rimanere prigionieri dei tedeschi, né aderire alla Repubblica di Salò,
riuscirono di notte col favore delle tenebre a guadagnare la libertà, facendosi
strada tra i proiettili delle sentinelle tedesche, che purtroppo fecero qualche
vittima tra i fuggitivi.
Bassano, con il
suo capitano, trovò, poi, fraterna accoglienza presso la Famiglia Marcacci, una
delle più distinte della zona, nella loro villa, a pochi chilometri da Livorno.
Questa famiglia era costituita da quattro sorelle, che furono
per Bassano più che
sorelle e non vollero mai - anche nei momenti più pericolosi e tristi dei rastrellamenti
degli uomini e particolarmente degli Ufficiali che non avevano aderito alla
Repubblica Sociale del nord, da parte delle SS tedesche -, abbandonare i loro
ospiti, anche se sapevano di rischiare, anch’esse, la deportazione, se non
addirittura la vita. Donne,
pertanto, di alta levatura morale, di animo forte e dotate di profondo amore
patrio e di sincera pietà (dalla “pietas” latina) cristiana.
Ma anche il periodo di attesa per ricongiungersi con il
Regio Esercito da parte dei due ufficiali non fu esente da rischi e pericoli,
perché era loro volontà non aderire alla Repubblica di Salò, ma reintegrarsi al
più presto con le Forze Regie, verso le quali avevano prestato giuramento di
fedeltà. Dal canto loro, i Tedeschi continuavano a rastrellare il territorio
ancora sotto il loro controllo ed a catturare gli uomini, tanto è vero che nelle campagne del livornese le donne in simili frangenti
giravano appositamente per avvisare gridando “acchiappall’omini” e tutti
scappavano nascondendosi come potevano.
I Tedeschi angariavano anche la
popolazione locale per approvvigionarsi e per rappresaglia ed in uno di questi
rastrellamenti Bassano si trovava nel suo rifugio presso la famiglia Marcacci,
mentre il suo Capitano si era occasionalmente allontanato. In quell’occasione si
presentarono a Bassano due delle sorelle Marcacci, cercando aiuto, disperate ed
in lacrime, chiedendo di intervenire perché due Tedeschi, entrambi appartenenti
alle SS, volevano prendere in ostaggio il figlio undicenne -unico figlio ed
unico nipote di tutte le quattro donne-. Infatti, i due militari tedeschi
avevano requisito un’infinità di prodotti della vasta campagna di proprietà
delle sorelle, svuotando le dispense ed i magazzini destinati al sostentamento
anche dei contadini ed ammassando ogni ben di Dio su di un capiente camion. A
quel punto, i due militari, per assicurarsi di non essere poi assaliti dai
contadini inferociti durante l’attraversamento delle campagne, avevano preso
come ostaggio il figlio di una delle sorelle, appena undicenne. Bassano, all’epoca
ventitreenne, in assenza del suo Capitano e sentendosi vincolato alla
riconoscenza nei confronti di quelle donne, si disse pronto ad intervenire.
Corse insieme a loro e si presentò ai due sottufficiali tedeschi così come era,
ovvero in abiti civili, dicendo di lasciare il bambino e di prendere lui, un
uomo, al suo posto. I due furono irremovibili, ma presero anche Bassano senza
lasciare andare via il ragazzo. Bassano e Francesco salirono allora sul camion
e, dopo un pò, i due tedeschi, ormai fuori dalla zona da loro ritenuta
pericolosa, dovevano decidere cosa fare dei due ostaggi e decisero di
eliminarli. Gli fecero scavare una buca per sotterrare i loro stessi corpi e,
quando fu tutto chiaro, Bassano supplicò i due di uccidere lui, ma di lasciare
andare Francesco: ci furono momenti drammatici in cui Bassano cercò di
strappare dalle loro mani il bambino, nonostante fosse sotto il tiro delle
pistole puntate su di lui. Ma non spararono, anzi uno dei due, il maggiore in
grado ed il più anziano, forse colpito per il gesto di coraggio del giovane e
mosso a compassione per la sorte del bambino, che piangeva disperato,
rivolgendosi in lingua tedesca all’altro gli ordinò di lasciarli andare. A quel
punto i due militari incominciarono a litigare violentemente tra loro, perché
il più giovane voleva invece eliminarli, e vennero anche alle mani, fino a che
il superiore non arrivò a puntare addirittura l’arma contro il suo sottoposto, contemporaneamente
urlando a Bassano di scappare insieme al bambino. Corsero per ore, fino a che
non entrarono nel latifondo delle sorelle Marcacci, dove i contadini
riconobbero il bambino e li riportarono indietro a casa su un carretto: furono
festeggiati per giorni entrambi.
Quel bambino divenne un uomo e per tutta la vita di Bassano
non fece passare mai un Natale, una Pasqua o un onomastico senza chiamarlo al
telefono, fino a che, il giorno di san Bassano del 2003, rispose al telefono di
casa solo la moglie Clara, comunicandogli che proprio quello stesso giorno
Bassano era venuto a mancare: a quel punto Francesco si sciolse in un pianto
dirotto, fino a non poter più proseguire la telefonata, mai dimentico del
bambino che era stato e dell’uomo che, pronto a rinunciare alla propria, gli
aveva salvato la vita.
Così si arrivò all’agosto 1944, quando gli Alleati, a cui
si erano affiancate le Truppe del Regio Esercito, giunsero nei pressi di
Livorno. Bassano,
insieme al suo Capitano, approfittando di tale situazione e sempre con l’aiuto
della Famiglia Marcacci, raggiunse, attraverso le linee, la zona occupata dagli
americani e, dopo un viaggio fortunoso, arrivò a Roma. Qui, il Capitano
proseguì verso Napoli, sua città, e Bassano verso Tagliacozzo, dove si ricongiunse al padre. Nel gennaio
1945, riprese servizio e fu assegnato alla 266a Compagnia Autonoma
Autieri A.C. (Allied Comission), dipendente dal Quartier Generale Alleato in Roma.
Il dopoguerra
Il 1° settembre 1946 passò in servizio al 21° Autoreparto
Speciale, sempre in Roma, trasformatosi, poi, in Reparti Auto dello S.M.E. ed,
infine, in Autogruppo dello S.M.E.
Nel marzo 1947,
a seguito di una proposta dei suoi Superiori diretti
durante la Campagna
di Russia, fu trasferito in Servizio Permanente Effettivo per Merito di Guerra
con la seguente motivazione:
“Ufficiale
automobilista comandante di Autosezione di non comuni qualità ha sempre
prodigato le sue energie al servizio. Nel corso di un ripiegamento del fronte
subiva ripetutamente l’attacco di preponderanti forze corazzate e di fanteria
nemiche. Nonostante la
notevole inferiorità numerica e di
armamento, affrontava con i suoi uomini il combattimento, riuscendo col suo
coraggio, la sua azione personale
di comando, il suo valore, la sua preparazione
tecnica e il suo spirito di iniziativa, a disimpegnarsi
brillantemente e raggiungere, dopo aver subito elevate perdite di uomini e di
automezzi, la zona prestabilita.
Luminoso esempio di coraggio, spirito di sacrificio e sprezzo
del pericolo.”
Nel contempo, non appena arrivato a Roma, aveva ripreso gli
studi universitari, conseguendo la
Laurea in Giurisprudenza. Successivamente, superò gli esami di
Stato per Procuratore Legale, ma non poté, peraltro, iscriversi all’Albo dei
Procuratori Legali, essendo Ufficiale Effettivo dell’Esercito.
In quel periodo, inoltre: prestò servizio presso i
Distaccamenti, dipendenti dal suo Autogruppo, prima a Ugovizza presso Tarvisio
(Udine) e poi a Casarsa della Delizia (Pordenone), impegnati nel recupero e smistamento
di autoveicoli dislocati in Austria e ceduti dall’Esercito Americano a quello
Italiano (dicembre 1947/maggio 1948); frequentò un Corso di Addestramento sulla
Motorizzazione e da Istruttore presso una Scuola dell’Esercito U.S.A.,
dislocata a Eschwege (Germania), nel periodo settembre-novembre 1948.
L'esperienza in Somalia
Il 26 agosto 1949, fu trasferito, a domanda, al Comando del
Corpo di Sicurezza della Somalia (ex colonia, data in mandato fiduciario
all’Italia dall’O.N.U.) e assegnato all’Autoreparto Misto “S” in approntamento.
Prestò servizio presso questo Reparto prima a Bari (agosto-novembre), poi a
Caserta (novembre-marzo); durante questi mesi, l’Unità venne costituita nei
mezzi e nel personale (Cap.no Comandante Tombesi; V. Comandante, Ten. Secchi; Com.ti di Autosezione,
Ten. Pizzillo, S. Tenenti Barbagallo, Menna , Gafforio).
Il 5 marzo 1950, Bassano s’imbarcò sulla Motonave “Andrea
Costa” e sbarcò a Mogadiscio il 20 marzo.
 |
| Bassano Secchi in Somalia (1950-1952). |
L’Autoreparto, unica unità del Corpo Automobilistico in
Somalia, veniva impiegato in tutto il Territorio da Bender Cassim (Migiurtinia)
a Chisimaio (oltre Giuba) senza mai un attimo di sosta. Il 12 luglio 1950, Bassano venne
promosso Capitano (con anzianità 15 marzo dello stesso anno) e il 10 marzo 1951
assunse il comando dell’Autoreparto Misto, iniziandone la trasformazione da
personale nazionale (Sottufficiali e Autieri) a personale somalo. Il 3 giugno
1952, lasciò in aereo la
Somalia dopo più di due anni di permanenza e rientrò in Italia.
La carriera negli anni Cinquanta e Sessanta
Il 26 ottobre 1952, finita la licenza coloniale, assunse il
comando del Reparto Trasporti della Divisione “Granatieri di Sardegna” con sede
a Roma - Pietralata (Caserma “Gen. Gandin”). Con questo Reparto partecipò alle
Grandi Esercitazioni dell’estate 1953, le prime Grandi Manovre effettuate dopo
la fine della guerra.
Il 14 gennaio 1954, venne trasferito al Ministero Difesa -
Esercito in servizio presso l’Ispettorato Generale della Motorizzazione. In
questo periodo fu:
-
Ufficiale Addetto alla Sezione Carburanti dell’Ufficio
Autoveicoli e Carburanti (19 gennaio 1954/30 settembre 1954; Col. Belluzzi,
Magg. Fabiano);
- Prescelto, a seguito domanda, quale frequentatore del 9°
Corso Superiore della Motorizzazione, superato con successo presso il Centro
Studi ed Esperienze della Motorizzazione (1° ottobre 1954/30 giugno 1955; Direttore
Col. SteM Noya);
- Assegnato alla Divisione Auto, quale Addetto alla Sezione
Personale Ufficiali (1° luglio 1955/30 giugno 1957; Capo Sezione, T.Col.
Amendolagine);
- Promosso Maggiore il 1° gennaio 1956;
- Vincitore di un concorso per titoli (1° classificato) per
la frequenza del Corso di S.M. presso la Scuola di Guerra (Civitavecchia):
gennaio-settembre 1957, corso propedeutico con esami finali; ottobre 1957 -
giugno 1958, frequenza 80° Corso Superiore di S.M. ed esami finali superati con
successo; conseguita, pertanto, la qualifica di t. SG (titolo Scuola di Guerra);
- Riassegnato alla Divisione Auto, quale Addetto alla Sezione
Addestramento e ordinamento. Per un anno ricoprì anche la carica di Capo
Sezione Personale Ufficiali, in sostituzione di collega in comando. Periodo dal
1° luglio 1958 al 30 gennaio 1964 (Capo Sezione: prima T.Col. Calò, poi T.Col.
Calabresi);
- Nel frattempo, promosso Ten. Colonnello il 1° gennaio 1963;
- Trasferito, il 31 gennaio 1964, al Comando delle Scuole
della Motorizzazione in Cecchignola, per effettuare il previsto periodo di
comando, quale Comandante dell’Autogruppo Allievi Sottufficiali presso la Scuola Meccanici
e Conduttori Automezzi (SMeCA), nella Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia”
(Comandanti: SMeCA, Col. Armando Iannace; Scuole Motori: Gen.le Manlio Timeus
e, successivamente, Gen.le Sebastiano Alfonso);
- Trasferito il 4 febbraio 1965 allo Stato Maggiore Esercito
per l’Ufficio trasporti, con l’incarico, prima, di Ufficiale Addetto alla 2a
Sezione (Piani) e, successivamente, Capo della 4a Sezione (Via
ordinaria e Ferroviaria). Capi Ufficio: Col. Mari, Col. Felcini, Col. De Paoli.
Lasciò lo S.M.E. il 21 settembre 1969, perché inviato in comando;
-
Promosso Colonnello in data 31 dicembre 1968.
 |
| Bassano Secchi, tenente colonnello. |
La promozione al grado di Colonnello nel Corpo Automobilistico
era allora una delle mete più ambite nelle carriera, in quanto solo una
ristrettissima percentuale di Ufficiali riusciva a pervenire a tale grado. Fu,
perciò, questo evento di grande soddisfazione per Bassano, evento che,
peraltro, chiudeva, nello stesso tempo, un ciclo della sua vita. Ma, nel lungo
periodo dopo il rientro dalla Somalia, si verificarono eventi familiari che,
per Bassano, furono
certamente più importanti della sua stessa carriera.
Infatti nel 1954, contrasse matrimonio con Clara Mary ONOFRI bellissima
ragazza statunitense di origine italiana e, precisamente, abruzzese, figlia di
un imprenditore di Yonkers nello stato di New York, con cui ebbero due figli,
una femmina e un maschio.
 |
| Sfilata del 2 giugno 1964 a Roma. |
Bassano,
intanto, proseguiva nella sua carriera e, promosso come già detto Colonnello,
il 22 settembre 1969 veniva trasferito in comando a Bologna (6a ORME
- Via San Donato), ove si recò da solo, lasciando la famiglia a Roma, onde non
sottoporla ad un disagevole trasferimento. Il 3 maggio 1971, peraltro, rientrò
a Roma, dove assunse l’incarico di Capo Ufficio Motorizzazione dell’Ispettorato
Logistico dell’Esercito.
La carriera negli anni Settanta e Ottanta
Il 31 dicembre 1973, Bassano viene promosso Maggior Generale, soddisfazione veramente
grande questa, poiché a tale alto grado riusciva ad arrivare, nel Corpo
Automobilistico, solo una percentuale minima di Ufficiali.
 |
| Bassano Secchi, maggior generale, nel 1975. |
Dopo il primo
servizio prestato nel nuovo grado come Generale Addetto al Comando del Corpo
(31 dicembre 1973 - 10 gennaio 1975), assunse l’11 gennaio 1975 il prestigioso
incarico di Comandante delle Scuole della Motorizzazione e, contemporaneamente,
quale Ufficiale più elevato in grado, anche il comando del Presidio Militare
della Cecchignola, uno dei Presidi più importanti dell’Esercito. Le Scuole
della Motorizzazione comprendevano: Scuola di Applicazione del Corpo Aut.co
(Caserma Arpaia), Scuola Meccanici e Conduttori di Automezzi (SMeCA - Caserma
Emanuele Filiberto), Scuola Specializzati (Caserma Ponzio), un Autogruppo di
Manovra e una Officina Media; un complesso forte di circa 5.000 uomini (tale complesso,
nella seconda metà degli anni ’80, subì una serie di modifiche organiche e
d’impiego, trasformandosi nella Scuola Trasporti e Materiali; alla fine degli
anni ’90, inoltre, anche il Corpo Automobilistico subì importanti modifiche,
trasformandosi in Arma). Il Presidio della Cecchignola aveva, a sua volta, una
forza di circa 10.000 uomini.
Lasciato il Comando delle Scuole della Motorizzazione e del
Presidio Militare della Cecchignola in data 10 gennaio 1977, Bassano
ricoprì, presso il Comando del Corpo, gli incarichi, prima, di Capo Nucleo
Ispettivo e, successivamente, di Capo del 1° Reparto (Ufficio Personale
Ufficiali e Sottufficiali, Ufficio Addestramento e Ordinamento, Ufficio
Regolamenti) dall’11 gennaio al 31 dicembre 1981.
Il 1° gennaio 1982, Bassano, a seguito di una legge relativa agli organici dei
Colonnelli e Generali dell’Esercito, viene collocato in “aspettativa per riduzione
di Quadri”, posizione nella quale permane fino al 24 agosto 1984, data sotto la
quale, raggiunto dai limiti di età, è collocato in congedo.
 |
| Il congedo dal servizio attivo , nel 1982. |
Si concludeva così la sua carriera dopo più di 43 anni di
servizio attivo.
Inoltre, il 23 maggio 1995, veniva conferito a Bassano il
grado di Generale Ispettore (grado equivalente a quello di Gen. di Corpo
d’Armata), in base alla legge 325/90 relativa al riconoscimento della
promozione al grado superiore per i combattenti della 2a guerra
mondiale.
Gli rimanevano come ricordo di questa lunga vita militare:
il grado di Generale Ispettore; una promozione per Merito di Guerra; la Croce al Merito di Guerra;
le Medaglie di Volontario di Guerra, della Guerra 1940-43 (con due Campagne:
1942-1943), della Guerra di Liberazione (una Campagna: 1945) e al Merito di
Lungo Comando; la Croce
d’Oro per Anzianità di Servizio; la
Medaglia d’Oro Mauriziana e la Commenda dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana; ma, soprattutto, gli rimaneva la sicura
coscienza di avere compiuto il proprio dovere verso la Patria e verso il Paese
(due entità ben distinte, ma integrantesi) con entusiasmo, con profonda
convinzione e con spirito di sacrificio, sempre e ovunque, in pace e in guerra.
 |
| Il medagliere del gen. Bassano Secchi. |
Si apriva, per contro, l’ultimo capitolo della sua vita.
Moriva il 19 gennaio 2003, proprio il giorno del suo
onomastico. Colpito da un male incurabile, sopportò la sua malattia con estrema
dignità e discrezione, minato nel fisico, mai nell’animo, fino all’inevitabile
epilogo.
Al funerale celebrato il 21 gennaio 2003 parteciparono,
oltre parenti e amici, Autorità militari e rappresentanza d’Arma. La chiesa era
gremita all’inverosimile, segno di una vita sempre spesa a servire la Patria e ad aiutare il
prossimo. Gli onori militari gli furono tributati da parte di un drappello di Autieri,
dovuti al suo alto grado e al passato di combattente, ma soprattutto all’ultimo
rappresentante della “Vecchia Guardia” di ufficiali e gentiluomini. Palpabile
fu la generale commozione, quando al termine della funzione si levarono dal
trombettiere le note del “Silenzio” in onore di un vecchio soldato tanto
generoso e amato.
Come da suo desiderio ora riposa nel locale cimitero di
Tagliacozzo, vicino al padre, il cui esempio di virtù e coraggio fu sempre
seguito con profondo affetto filiale.
Enrico Secchi